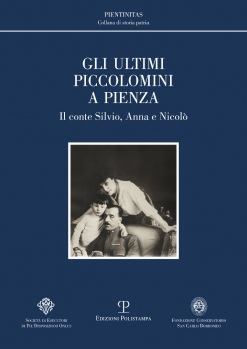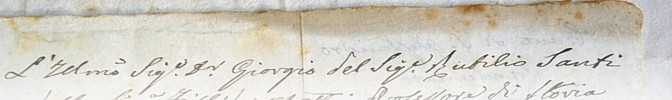I “paracarri” di Pienza
di Aldo Lo Presti
Interessarsi dei cosiddetti “paracarri” o “scansaruote”, veri e propri “strappi del passato” (per usare le parole di Gadda) e già utilizzati a Pompei per delimitare le vie pedonali, trova una doppia ragione nel loro essere “…parte del paesaggio urbano e allo stesso tempo testimonianza di cultura materiale”.[1]
Manufatti che però, alla stregua di ogni altro dettaglio paesaggistico urbano (come le diverse tipologie degli ormai del tutto inutili “nettascarpe”) la cui efficacia s’è ormai degradata, rischiano una non certo auspicabile invisibilità se non addirittura un’oggettiva distruzione a causa della loro “sommersione” per via di progressive asfaltature delle strade o dei cortili interni degli edifici.[2]
Si ricorda, a tale proposito, che i “paracarri” altro non sono se non quelle colonnette o piccole piramidi sistemati presso gli spigoli dei portoni per salvaguardarne l’integrità che veniva messa a repentaglio dai mozzi delle ruote dei carri che vi transitavano.
Tali “paracarri” erano fabbricati generalmente in pietra (oppure frutto di spoliazione e riutilizzo di antichi reperti romani, come nel caso di Venafro o Brindisi) ma anche in ferro o in ghisa, come quelli decorati con foglie d’acanto stilizzate[3] che sopravvivono presso l’ingresso di “servizio” del palazzo Piccolomini a Pienza.
La durezza e solidità del materiale dei “dissuasori” pientini, ha impedito la formazione dei tipici solchi causati dalle ruote dei carretti che vi urtavano ogni giorno (come non ha tralasciato di segnalare Proust nella Recherche); si tratta di una tipologia riferibile alla seconda metà del XIX sec., la stessa che si rintraccia, ad esempio, sia in via del Seminario a Roma,[4] e più precisamente all’altezza del numero civico 87, sia ad Orvieto a far da guardia al portone laterale del palazzo Gualterio di C.so Cavour.
La coppia di “paracarri” orvietani, esempio residuale di decoro cittadino modellato in fusione, e gli analoghi “gemelli” pientini, sono gli ultimi manufatti esistenti in metallo, muti e silenziosi testimoni di un’epoca di “buone maniere” (volenti o nolenti) quasi del tutto fuori moda.
E si scrive “quasi” per un estremo sussulto di ottimismo.


[1] Colanzigari Olga, Guidi Alessandro, Archeologia del nettascarpe. La cultura sotto i piedi, in Atti del quarto convegno di Etnoarcheologia, Roma, 17-19 maggio 2006, Archaeoress Publischers of British Archaeologicl Reports, Oxford, p. 17.
[2] Maroni Lumbroso Matizia, L’età del cavallo. Ricerche 1969-1976. Fondazione Marco Besso, Roma, 1977, pp. 9, 11, 12.
[3] «È a tutti noto il racconto che fa Vitruvio circa l’origine del capitello corinzio, attribuendone l’invenzione all’orafo Callimaco, che volle in un capitello imitare un cespo di acanto fiorito intorno ad un paniere […] L'abuso fatto in tutte le età, in Italia e fuori, della foglia d'acanto è dovuto non solo alla bellezza della pianta, ma soprattutto alla sua natura flessuosa, per cui può facilmente prestarsi, senza subire variazioni disarmoniche, alle decorazioni più varie». Vedi: http://www.treccani.it/enciclopedia/acanto.
[4] Maroni Lumbroso Matizia, L’età del cavallo…, op. cit., pp. 9, 11, 12.